Ci portano il caffè e le paste, io sono tutta stordita mi gira la testa per via di quel suo modo di parlare come un sonnambulo. Quella franchezza improvvisa. Quella violenza. I suoi occhi che mi fissano gli occhi di Assi uno sguardo doppio gli occhi castani chiari. Il ritmo della parlata melodica diretta spudorata mi aggredisce. Lo volevano ammazzare? Dio mio di chi parla? Ma ho sentito bene? È malato anche lui. In che razza di famiglia sono capitata. Dolce terrore. Lui si china sulla pasta, la fiuta con sensualità. […]
La velocità la franchezza diretta il pizzico di malignità io crollo sotto il peso della pioggia delle parole tremo arrossisco i raggi del sole mi inondano gli occhi il brusio della gente che mi circonda. Tra poco Assi sarà a casa. Tutto mi è stato scaraventato addosso così all’improvviso. Emozione profonda. Lui inghiotte il resto della pasta beve il caffè a occhi chiusi, poi sorride, si guarda intorno.
– Ma io non capisco… chi era che ti voleva assassinare?
Mi fissa. Tira fuori una sigaretta l’accende spezza con forti dita il fiammifero bruc
iato.– Non lo sapevi? Davvero? Non ti hanno detto nulla? Assa difende il nostro buon nome. Da quanto tempo siete sposati? Se non l’hai ancora lasciato non lo lascerai adesso per questo motivo. Ah ah ah…
Sono stordita spaurita al vedere come lui d’un tratto ride, un riso così osceno.
– Cosa…?
– Non ha importanza… Se non te l’hanno detto, non ha importanza. Quello che è stato è stato e il passato è morto e sepolto…
Ma all’improvviso cambia idea, si china, si copre di una nuvola di fumo, accosta il suo viso al mio, sussurra febbrilmente.
– Chi? Ma lei, naturalmente. Per quale altra ragione lei dovrebbe essere lì dov’è e io dove sono? Davvero non te ne hanno mai neppure accennato? Posso immaginare… Un giorno, quando di me non sarà rimasto che un pugno di cenere, Zwi ti racconterà una storia, di come mi ha visto coi suoi occhi riverso nel sangue, in corridoio, fra le due camere, vicino alla cucina…
E si scioglie il nodo della cravatta, slaccia due bottoni della camicia, e indica fra la peluria grigia una striscia rosea, una cicatrice tratteggiata come se avessero cercato di scriverci sopra qualcosa, che per un attimo si scopre e subito scompare. Un raggio di sole gli balza sul viso. Mi prende di nuovo la mano. […]
Adesso mi è chiaro. Un personaggio da racconto. Di più, un protagonista per un intero romanzo. Se restasse qui con noi lo sfrutterei gli smonterei di dosso interi pezzi e li metterei sulla carta, copierei intere frasi direttamente dalla sua bocca. Quanto poco Assi sa capire gli altri. Mille volte gli ho chiesto tuo padre cos’è e lui mi ha saputo dare solo uno sbiadito stereotipo. E invece questo è un uomo-miniera. Il suo aspetto, le sue folte sopracciglia i baffetti, il fiume di parole la franchezza e l’astuzia. Forse. La calda tazza di caffè stretta forte fra le mie mani. Un rivolo caldo mi gocciola giù nelle viscere. Sono ormai più di due settimane che non mi tocca. La sua valigia stretta fra le mie gambe mi accarezza la pelle. Gente ci passa intorno mi sfiora i capelli. L’aria si fa sempre più calda. Un improvviso forte odore di primavera. Mi apro un bottone della camicetta sono improvvisamente eccitata. Il dolore delle parole. Non posso trattenermi, prendo dalla borsa il taccuino e annoto velocemente desiderio rugoso spezzato. Miniera-uomo. Chiudo ributto dentro. Lui mi guarda con un sorriso sapiente.
– Hai catturato una parola? Anch’io quand’ero giovane andavo sempre in giro con un taccuino così.
Abraham B. Yehoshua, Un divorzio tardivo. Traduzione di Gaio Sciloni, Einaudi 1996.
Cosa succede quando si legge? In questo caso, cosa succede quando leggo questo romanzo, questo romanzo di Yehoshua? Questo divorzio tardivo in cui così velocemente si sprofonda, tanto da leggervi cartografie biografiche personali e possibili percorsi letterari in aggiunta, come se questo romanzo stesse lì come una tela pronta per essere ricamata, sald o e familiare supporto di altre storie, di altri tardivi divorzi, rimorsi, rimossi.
o e familiare supporto di altre storie, di altri tardivi divorzi, rimorsi, rimossi.
Non posso che partire da questa domanda per provare a raccontare questo libro, o meglio i suoi contraccolpi: cosa succede quando si legge. Quando si legge un libro che fa questo effetto, che diventa vero in un attimo e vivo resta anche dopo l’ultima pagina. Alle volte succede con la saggistica, con i pensatori che diventano chiavi per smontare altre situazioni, altri testi. Ma quando succede con una storia, non è proprio la stessa cosa. Perché ad esempio questa, di storia, è puntellata da una miriade di descrizioni silenziose, descrizioni che fanno parte dell’azione e non l’arrestano, la scavano piuttosto, facendola apparire nella sua lucentezza familiare. Azioni, frasi, che vengono da sé, fermentate da odori, ricordi, ragionamenti: ma tutti i tratti che ne preparano gli strappi – degli strappi folli, che a considerarli da svegli sembrano sbucati fuori dal nulla, senza storia né motivo – sono estremamente lievi, delicati ed esatti. Piccole paroline che con un chiacchierio misuratissimo costruiscono un altro mondo, immediatamente familiare. Penetriamo in lui dall’interno, introdotti da cugini, mogli e fratelli, e forse per questo ci si affeziona così in fretta; non c’è spazio per le assenze distanti, quelle non chiare, un po’ vuote di pensiero, né per la noia: c’è molto di questo spaesamento, ma le relazioni mancate da cui esso scaturisce sono penetrate e analizzate acutamente, siamo condotti a viverlo nella tasca nascosta di qualcun altro, qualcuno in costante dialogo con se stesso e con ciò che lo circonda, siano le paste sensuali o gli sguardi dei passanti.
Un divorzio tardivo è del 1982, secondo romanzo di Yehoshua. La storia si svolge durante i giorni che precedono la Pasqua ebraica, in ognuno dei nove capitoli il narratore è un diverso membro della famig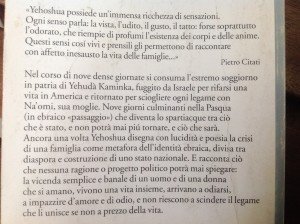 lia, e cambiando gli stili di narrazione, inutile dirlo, si compone ancora più verosimilmente la memoria di quei giorni precedenti al passaggio. Tutto ruota intorno al breve ritorno in Israele dell’ormai anziano Yehudà, fuggito in America per dimenticare la cicatrice israeliana, e alla sua complicata volontà di chiudere i rapporti con la moglie. Ma la cicatrice lì rimane, anzi viene continuamente esposta, mostrata, indicata, raccontata, viene usata per scandalizzare, ma in modo autentico: Yehudà che cerca di impressionare cerca di leggere negli occhi a cui la svela una risposta, un’altra traccia che lo corrisponda e possa salvarlo, chiudendo una volta per tutte la ferita. La trova solo nell’arborea casa di cura dove abita la moglie, la sempre-quasi-ex-moglie, la moglie spaccata in due, dopo il processo dopo la giustizia prima ci vuole lo stare insieme, la moglie che cercava di parlare attraverso abominevoli combinazioni di cibo propinate con insistenza, biscotti ripieni di cetrioli, teste di pesce congelate, miscugli di pasti del cane, pane pesto, nell’odore di marcio che impregnava la casa, il marcio della sua pazzia senza ritorno che cercava di spaccare in due, per potervisi ricongiungere, il più amato.
lia, e cambiando gli stili di narrazione, inutile dirlo, si compone ancora più verosimilmente la memoria di quei giorni precedenti al passaggio. Tutto ruota intorno al breve ritorno in Israele dell’ormai anziano Yehudà, fuggito in America per dimenticare la cicatrice israeliana, e alla sua complicata volontà di chiudere i rapporti con la moglie. Ma la cicatrice lì rimane, anzi viene continuamente esposta, mostrata, indicata, raccontata, viene usata per scandalizzare, ma in modo autentico: Yehudà che cerca di impressionare cerca di leggere negli occhi a cui la svela una risposta, un’altra traccia che lo corrisponda e possa salvarlo, chiudendo una volta per tutte la ferita. La trova solo nell’arborea casa di cura dove abita la moglie, la sempre-quasi-ex-moglie, la moglie spaccata in due, dopo il processo dopo la giustizia prima ci vuole lo stare insieme, la moglie che cercava di parlare attraverso abominevoli combinazioni di cibo propinate con insistenza, biscotti ripieni di cetrioli, teste di pesce congelate, miscugli di pasti del cane, pane pesto, nell’odore di marcio che impregnava la casa, il marcio della sua pazzia senza ritorno che cercava di spaccare in due, per potervisi ricongiungere, il più amato.
Ma davvero? Sul serio? Volevi ammazzarmi? Forse la cosa perfino ti piace, adesso che stiamo per separarci. Sí, ho detto, ma in realtà no. Spaccare. Fa differenza, non capisci? Spaccare fra la paura disperata che voleva ormai fuggire e lasciare qualcosa che sarebbe rimasto, qualcosa certo sarebbe rimasto. Spaccare fra la contrazione della paura e lo spirito che spiega se stesso, che fruga in se stesso e si volge ansioso verso il mondo per una missione immaginaria, suicida.
Così quella cicatrice rosea, fine come un becco ricurvo, tratteggiata come se avessero voluto scriverci sopra qualcosa, chiama nuove parole che la catturino. Non per tentare di chiuderla, ma per ritracciarla, per ritracciare quel desiderio rugoso spezzato, finalmente spezzato, di passare.
